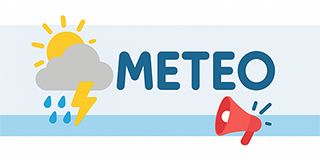IntervisteScienza e TecnologiaTorino
Intervista a Beatrice Demarchi, bioarcheologa dell’Università di Torino: dalla ricerca sul rinoceronte estinto alle meraviglie dello studio del passato
«Il fatto che ci siano delle tracce invisibili di vite passate che noi possiamo leggere con tecnologie avanzate non può che essere fonte di interesse, anche per il pubblico»

TORINO – Un “tuffo” indietro nel tempo. Vi avevamo già parlato di un’importante ricerca internazionale nell’ambito degli studi sulle molecole fossili a cui hanno partecipato due studiose dell’Ateneo torinese. Il team guidato dal professor Enrico Cappellini, anche lui torinese, dell’Università di Copenaghen, ha analizzato il fossile di un Epiaceratherium, un antico progenitore dei rinoceronti, sfruttando le informazioni ricavate dallo studio delle proteine recuperate dallo smalto dentale del campione, datato tra i 21 e i 24 milioni di anni.
Per capire quale sia la portata di questo studio, svolto in Canada nel freddissimo sito del cratere di Haughton, abbiamo fatto visita nel suo ufficio torinese alla professoressa Beatrice Demarchi, ordinaria di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Torino. Beatrice, insieme alla dottoranda Meaghan Mackie, ha partecipato attivamente a questa ricerca. Nell’intervista ci spiega in che modo ha contribuito, e ci svela il “dietro le quinte” del suo lavoro e della disciplina di cui è esperta, la bioarcheologia. Non disdegnando di darci qualche interessante spunto di riflessione sul valore delle conoscenze scientifiche, anche di quelle relative al passato che hanno però notevoli implicazioni sul presente e sul nostro futuro.
Professoressa Demarchi, se dovesse spiegare in poche parole a un pubblico non esperto il motivo per cui questa ricerca è rilevante cosa direbbe?
«Allora, la scoperta è importante soprattutto dal punto di vista metodologico: per la prima volta grazie alla proteomica riusciamo a ottenere delle sequenze di proteine così antiche. Di solito è difficile ricavare il DNA dai fossili, perché degrada rapidamente. Il DNA molto antico è stato ottenuto solo in condizioni eccezionali. Le sequenze di nucleotidi che compongono il DNA possono deteriorarsi nel tempo e rompersi, e quando questo succede è difficile recuperare le informazioni perse sul genoma del fossile, perché non siamo in grado di ricostruire le sequenze originarie. Ora, le proteine sono prodotte seguendo le istruzioni contenute dal DNA. In questo studio, il team ha estratto proteine che contenevano ancora informazioni filogenetiche, cioè che ci danno la possibilità di comprendere la vicinanza evolutiva tra diverse specie, nel nostro caso tra il rinoceronte estinto e altri rinoceronti estinti o altri taxa [raggruppamenti di organismi distinguibili morfologicamente e ordinabili gerarchicamente, ndr]. È un lavoro che si basa anche su studi che abbiamo fatto già dieci anni fa a partire da uova di struzzo in Africa e in Asia: in queste uova abbiamo trovato proteine molto antiche, fin dal Miocene Tardo [11.64-5.333 milioni di anni fa, ndr] nel caso di quelle ritrovate in Asia. Di solito, però, in questi siti la temperatura è alta e la sequenza si disintegra molto più velocemente; di conseguenza, non sempre riusciamo a ricavare informazioni utili. Il luogo dove è stato condotto lo studio sull’Epiaceratherium, ovvero il cratere di Haughton in Canada settentrionale, presenta invece un clima molto rigido, più adatto alla conservazione delle sequenze. Proprio per questo motivo i ricercatori sono andati lì: sapevano che potevano trovare le condizioni idonee per recuperare sequenze antiche poco danneggiate».

In foto uno dei piccoli prodigi della tecnologia che mi sono stati mostrati dalla professoressa Demarchi: un cromatografo liquido in uso presso uno dei laboratori del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi in via Accademia Albertina
Quindi, se capisco bene, alcune volte dalle proteine possiamo ricavare informazioni filogenetiche, altre volte no. In cosa consiste questa differenza?
«La differenza è la situazione conservativa, data dalla temperatura e più in generale dall’ambiente in cui è conservato il fossile. L’anno scorso abbiamo pubblicato uno studio in cui abbiamo tirato fuori amminoacidi da uova di dinosauro: tuttavia non abbiamo potuto ricostruire l’ordine con cui gli amminoacidi sono posizionati. L’ordine degli amminoacidi cambia il significato filogenetico, quindi da quel punto di vista quei campioni non erano particolarmente informativi».
Parlava prima di proteomica. Di cosa si tratta?
«È lo studio dei proteomi, cioè dell’insieme delle proteine e degli eventuali prodotti di degradazione che sono conservati in un campione. In questo studio è stato analizzato lo smalto dentale, che è molto resistente e protegge bene la componente molecolare. Per la precisione, lavorando su proteine di campioni antichi, chiamiamo questa attività paleoproteomica, che è simile alla proteomica su campioni recenti ma presenta delle difficoltà in più: le proteine sono degradate, quindi abbiamo bisogno di tool specifici che ci permettano di ricostruire le sequenze originali».
Il fossile che avete studiato è datato oltre 21 milioni di anni. Secondo lei con la proteomica si può andare anche più indietro?
«Del periodo tra la fine dei dinosauri e la comparsa degli esseri umani tutto sommato si sa poco; è studiato dai paleontologi, ma è poco noto: i fossili sono sempre troppo pochi, e studiare l’evoluzione solo da un punto di vista morfologico (quindi guardare alla forma) è complicato, perché per esempio la forma dello scheletro risponde agli stimoli ambientali. Nel futuro sarebbe bello affiancare sistematicamente le informazioni ottenute dalle biomolecole al lavoro dei paleontologi sulla base morfologica, per studiare meglio i fossili più antichi. Tuttavia, ho qualche dubbio che con l’identificazione delle proteine si possano studiare fossili molto più antichi rispetto a quanto siamo riusciti a fare con l’Epiaceratherium, ma è facile che io mi sbagli date le potenzialità delle nuove tecnologie. Forse, facendo studi sui proteomi in maniera più sistematica, si potrà andare un po’ più a ritroso nel tempo, ma c’è un limite oggettivo, che va oltre il miglioramento degli strumenti tecnologici: le proteine si degradano. Secondo me a Jurassic Park no, non ci arriviamo per intenderci…».
Ecco, non volevo chiederglielo ma viene spontaneo pensarci in effetti…
«Sì in realtà tanti ci provano da tempo, ma a mio parere non sono ancora riusciti a ricavare informazioni convincenti. Come dicevo prima, anche noi ci abbiamo provato dalle uova, ma senza successo. Le sequenze proteiche dei campioni erano contaminate: la contaminazione da proteine più recenti è un problema enorme per il nostro lavoro. Comunque, sono usciti diversi articoli nel passato che avevano questo claim secondo cui si erano recuperate sequenze integre di collagene [una proteina, ndr] di T-Rex…».
Anche l’analisi del DNA può quindi sovrapporsi a quella del proteoma?
«Sì, lo studio del DNA, la genomica, ci dice il codice genetico generale dell’organismo, mentre la proteomica fornisce informazioni specifiche sulle proteine di specifici tessuti. In tutte le cellule c’è lo stesso DNA, mentre nei tessuti biologici ci sono proteine specifiche. Recuperare le sequenze di proteine antiche ci permette di ottenere quindi conoscenze complementari».
Prima diceva che questa scoperta è importante soprattutto per la metodologia. Quali scenari si aprono ora per gli studi bioarcheologici?
«Diciamo che ora la sfida è non avere più un solo campione che funge da esempio metodologico, ma poter analizzare in modo più sistematico e ampio taxa specifici. L’obiettivo può essere studiare la variabilità intrinseca interna alle specie guardando ai risultati della paleoproteomica. Uno studio che stiamo per pubblicare fa vedere che anche all’interno della stessa specie alcune proteine hanno delle mutazioni, il che può andare a complicare la costruzione degli alberi filogenetici. Dovremo ora costruirli basandoci su tantissimi fossili e su tantissimi genomi moderni e antichi».
Quale contributo specifico avete dato lei e la sua équipe allo studio sul rinoceronte estinto?
«Io mi sono occupata di calcolare la thermal age del fossile: si tratta di un modo di stimare l’effetto combinato di temperatura e tempo sulla degradazione delle proteine. Meaghan, che ora è una nostra dottoranda, ha partecipato direttamente alla ricerca a Copenaghen».
Parte del suo lavoro si svolge anche sul campo?
«Sì, innanzitutto con il mio team lavoriamo con le istituzioni della zona per recuperare vecchi materiali di scavo – sia faunistici, sia resti umani: sono patrimoni bioculturali importantissimi e spesso poco studiati, e che oggi, grazie alle nuove tecnologie, possiamo indagare. Poi lavoriamo anche fuori Torino. Siamo impegnati in un grosso progetto chiamato AviArch, di durata quinquennale, finanziato dall’Unione Europea e incentrato sull’avifauna. In particolare, con AviArch studiamo la coevoluzione di esseri umani e uccelli, specie durante il Neolitico, quando si passa dalla caccia-raccolta-pesca all’agricoltura, e l’età del Bronzo, momento in cui nel Mediterraneo c’erano contatti a lungo raggio e gli uccelli venivano verosimilmente spostati lungo queste tratte. Stiamo proprio sviluppando in questo momento il metodo per riuscire a capire a che specie appartengono ossa e uova, e ricavare informazioni, per esempio sul paleoambiente che le ospitava. Abbiamo progetti in Messico e in Sudafrica. Una ricercatrice, Rivka, lavora sulla collezione di mummie del Museo di Antropologia ed Etnografia di Torino (chiuso al pubblico dagli anni ’80). Infine, siamo parte di un progetto internazionale enorme finanziato dal Regno Unito in cui studiamo lo stile di vita delle comunità monastiche nel Medioevo».

Una centrifuga per campioni da analizzare in dotazione del laboratorio di cui sopra, per il progetto AviArch
Da quante persone composto il suo team di ricerca?
«Solitamente ci sono 15 o 16 persone al lavoro. Io sono arrivata qui nel 2017 da sola, facendo domande di finanziamento ho ottenuto dottorandi e ricercatori postdoc. Purtroppo non si tratta di un gruppo di ricerca stabile, perché sono tutti contratti a tempo determinato; è questa un po’ la piaga del sistema, non si riesce a dare stabilità. Non dico a tutti ma almeno a qualcuno sarebbe carino poter dare una prospettiva. Certo è bello questo continuo ricambio di giovani con tante competenze ed entusiasmo, ma dare continuità alle ricerche così è difficile».
Come riesce a mettere insieme l’attività di ricerca con quella di insegnamento?
«Diciamo che ci facciamo un gran mazzo [ride, ndr], si cerca di far partecipare gli studenti. Abbiamo un sacco di tesisti che partecipano ai nostri progetti: vanno sul campo, lavorano in laboratorio, generano e analizzano i dati. Anche durante le lezioni si cerca di fare attività pratiche, e di portare spesso gli studenti in laboratorio».
E lei si trova ugualmente a suo agio in laboratorio come in aula?
«Sì».

Il corridoio della sede di via Accademia Albertina contente la galleria di anatomia comparata
Ma la bioarcheologia secondo lei può interessare anche un pubblico non specialistico? Se sì, perché?
«Io penso di sì…Il motivo è che è affascinante riuscire a rileggere le vite del passato. Noi bioarcheologi in qualche modo facciamo rivivere individui, animali e ambienti che oggi non ci sono; è il motivo per cui mi piace fare questo lavoro. Il fatto che ci siano delle tracce invisibili di vite passate che noi possiamo leggere con tecnologie avanzate non può che essere fonte di interesse, anche per il pubblico. Non solo, ci fornisce anche informazioni utili per il futuro: la bioarcheologia ci dice che le persone hanno trovato strategie di sussistenza in situazioni particolari, per esempio in cui non esisteva l’agricoltura come la intendiamo noi. È il caso della comunità di Teotihuacàn che sta studiando la nostra postdoc neozelandese Maria: lì c’era una popolazione di migliaia di persone che sopravvivevano senza praticare l’agricoltura. Quindi, questi studi ci danno delle indicazioni su come affrontare sfide ambientali che stiamo già vivendo. Noi abbiamo dei pregiudizi occidentali legati al nostro sostentamento, pensiamo che la nostra sopravvivenza sia dipendente dall’agricoltura intensiva e dall’industria, ma studiare il passato ci mostra che ci sono modi di vivere alternativi che abbiamo già adottato. E che poi abbiamo scartato, anche perché magari le popolazioni che seguivano questi stili di vita sono state colonizzate».
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese